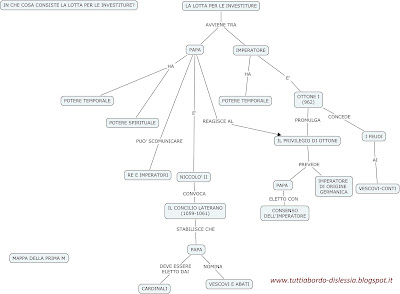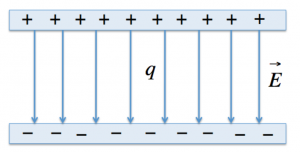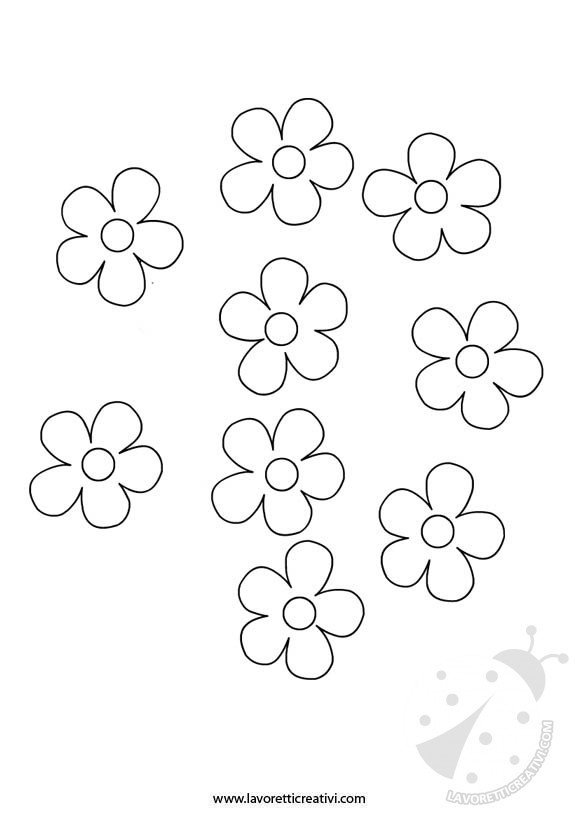PIEPOLI :HO SBAGLIATOMA VOGLIO RISCATTARMI
Piepoli: ho sbagliato, adesso "usatemi" «Pronto a fare qualsiasi cosa per riscattarmi come uomo» ESCLUSIVO | Non ha voglia di scherzare, lui che ha sempre avuto la battuta pronta e il gusto del paradosso. Non ha voglia di scherzare, ma un maledetto desiderio «di uscire dalla fogna», come ci dice amaro. Leonardo Piepoli non è più un ragazzino, e non ha nemmeno più i lineamenti del ragazzo imberbe e spensierato. Quelli forse non li ha neppure mai avuti, visto che il suo viso disegnato da una barba marcata e precoce lo rendeva più vecchio di quello che era anche agli inizi della sua carriera, quando per tutti era la «pulce di Alberobello» o il «trullo volante». «Ora invece sono solo un citrullo…», dice tra il sarcastico e l’amaro. Ci incontriamo a metà strada, in un locale di Fidenza, appena fuori dall’autostrada. È da quattro anni che si è eclissato, nascosto, annullato dal mondo. Poi una telefonata, a metà gennaio: «Ciao Pier, sono Leo, ti ricordi di me?…». E ancora: «Se sei in imbarazzo evito di andare avanti, posso capire che mi consideri un autentico pezzo di… D’altra parte io stesso mi considero esattamente così». Lo ascolto, parliamo un po’, ci diamo appuntamento per mangiare qualcosa insieme. Ha voglia di parlare, di raccontare quello che ha nella testa e sullo stomaco, ma soprattutto nel cuore. «Vengo da anni difficilissimi, fatti di vergogna e tormenti. I due anni che mi hanno dato per il doping? Sono nulla in confronto a quello che ho pasasto e sto passando. Mi sento un fallito, un perdente, un bandito, uno che è stato capace di rovinare tutto per la propria superficialità e il proprio ego. Oggi io non sono qui a chiedere di essere perdonato e capito, perché sono il primo che non si perdonerà mai. Non sono nemmeno qui a chiedere il diritto d’oblio, anzi, io la penso esattamente al contrario. Ho letto che ci sono personaggi del mondo della politica o dello spettacolo che fanno scrivere dall’avvocato affinché i giornali e i mezzi di comunicazione non facciano più riferimento a cose del loro passato, io questo non lo trovo giusto. Io so che ho sbagliato e so anche che chiunque e per tutta la vita ha il diritto di dire quello che feci in quella estate del 2008. Un conto però è ammettere i propri errori e un altro è fare qualcosa per poter diventare un uomo migliore. Ecco, io sono qui perché dopo aver visto gli occhi di mio figlio Yanis (5 anni, ndr), voglio che lui sappia che papà ha sbagliato, che è stato un cretino, ma che un giorno ha anche avuto la forza di rialzarsi e ha saputo fare qualcosa di importante per ritrovare la strada maestra». Leo, cosa è successo nell’estate del 2008? «Mi sono sentito un padreterno. Mi sono sentito un dio, che era considerato e veniva considerato da Riccardo Riccò qualcosa di molto importante. Riccardo in quel momento era davvero tanto per il ciclismo italiano e mondiale. Dopo Armstrong c’era lui e Riccardo voleva me al suo fianco. Io ero il suo alter ego: per me il massimo del massimo. In quel periodo pensavo a cosa potessero provare gli uomini di fiducia di Marco Pantani: cose da perdere la testa. Difatti io l’ho persa. A maggio mi ero ritirato dal Giro d’Italia: cado lungo la discesa del Falzarego, mi fratturo quattro costole e abbandono. In programma c’è la Vuelta, ma Riccardo mi chiede di andare con lui al Tour: sono affascinato dall’idea. E soprattutto lusingato». E poi?… «Potrei limitarmi ad aiutarlo, a fare quello che ho sempre fatto nella mia carriera: far vincere i miei capitani. Invece nell’euforia del momento perdo il senno, e mi faccio abbacinare dall’idea di poter fare qualcosa di grande. Entro in quel tunnel fatto di delirio di onnipotenza ed eccitazioni, convinto da chi di solito ti dice che tanto nessuno ti può beccare, e io poi stupidamente mi do anche una giustificazione: sono un po’ giù di preparazione, è giusto che un aiutino me lo dia. Incoscienza allo stato puro. Salgo su una giostra sulla quale non sarei mai dovuto salire. Riccardo per me è stato come Lucignolo con Pinocchio: io davvero ho avuto la testa di legno. Mi sono fatto ingolosire come un bimbo davanti ad una pasticceria. All’Hautacam vinco. Quel giorno so di aver rubato. Sento di averla fatta fuori dal vaso. Quello che dovrebbe essere il momento più bello della mia carriera, in verità si rivela il più brutto e buio di tutti. Io sono a disagio con me stesso. So quello che valgo, so quello che potrei fare con le mie sole forze». Tu prima, nella tua lunga carriera (14 anni di professionismo), mai avevi fatto ricorso alla chimica? «In pochissime occasioni. Quasi subito capii quello che ero. Di una cosa sono certo: anche se avessi preso tutto il doping del mondo io non sarei mai potuto diventare né Pantani né tantomeno Armstrong. Ma se è per questo nemmeno un Riccò o un Virenque, per essere chiari. Io ho sempre avuto un buon motore, capace di poter rendere nelle corse di una settimana: una tappa davvero dura e basta. Non per niente ho fatto incetta di Subida a Urkiola, o tappe e classifica finale al Giro d’Aragona o a quello delle Asturie. Difatti, su quelle mi sono specializzato. Quell’anno, invece, ho deciso di combinarla davvero grossa». Chi ti ha dato il Cera: un medico? «No, nessun medico. I medici spesso non centrano assolutamente niente. I pasticci li fanno i corridori, altro che storie». Perché non hai confessato subito le tue colpe? «Perché la cosa era più grande di me. Avevo paura, non sapevo cosa fare. Mi era crollato il modo addosso. Ho cominciato a correre a 9 anni. Da Alberobello avevo lasciato mamma Antonia, papà Oronzo e mia sorella Julia per andare a cercar fortuna al Nord. Prima in Piemonte con la Madonna di Campagna, poi al Casano con Luca Colombo e i fratelli Tomi, poi un anno in Friuli al Caneva e poi ancora al Casano. Tanti sacrifici, ma anche tanta passione. Per me il ciclismo era tutto. In un momento, al Tour, ho gettato alle ortiche tutto e mi sono trovato senza forze. Annientato, e incapace di capire cosa fare della mia vita. Una sensazione che è durata parecchio e che per certi versi non è ancora del tutto scomparsa. Sia chiaro: non ho mai cercato di essere perdonato. Oggi vivo ancora il profondo sconvolgimento di certi miei atti. Quando quest’estate ho letto le dichiarazioni del presidente dell’Uci Pat McQuaid che diceva che non ci deve essere più posto per chi ha barato, io mi sono sentito morire. Sì, si può morire anche guardando il mare... Oggi vivo di rimorsi, angosce e incubi. Mi ritornano in mente un sacco di orribili e angoscianti flash di momenti che mi hanno violentemente provato, momenti che vorrei evitare ad altri. Ho letto la tua intervista al pm di Padova Benedetto Roberti: capisco la sua posizione, la sua rabbia, ma penso che oggi il ciclismo sia molto meglio di quello di ieri. Più pulito del mio, per intenderci. Il ciclismo non è quello che racconta lui, non è il circuito Udace, non è nelle confessioni di persone disperate che compiono atti scellerati o di chi dice di aver visto qualcuno che al posto della borraccia aveva una flebo. Il ciclismo è nelle mani e negli occhi di tutti quei ragazzi - grandi e piccoli -, che rincorrono un sogno. Il ciclismo è nelle mani di chi si accampa e trascorre ore e ore a bordo strada per vedere una tappa di montagna. È nelle mani di quei corridori che hanno accettato e voluto il sistema Adams e anche il passaporto biologico. È nelle mani di quelle persone che hanno fatto una vera lotta al doping, dando la caccia ad intoccabili che evidentemente nel ciclismo non esistono: vedi il caso di Lance Armstrong. Non c’è da inventarsi niente, c’è solo da continuare nella direzione dell’Adams e del passaporto biologico. Bisogna andare avanti con i controlli interni e a sorpresa. C’è da adottare semplicemente il terrorismo psicologico: ragazzi, sappiate che noi siamo in grado di trovare tutto e tutto troveremo». Perché gli sportivi dovrebbero crederti? «Hanno tutto il diritto di considerarmi per quello che sono: uno che non ha giustificazioni. Ma sono qui per poter chiedere scusa. Io non voglio né medaglie né pacche sulla spalla. Ho passato mesi a far fatica ad alzarmi dal letto. O stavo a letto e rinunciavo a vivere, o mi alzavo e decidevo di fare qualcosa di buono dopo aver fatto qualcosa di tremendamente brutto. Come ti ho detto, mi hanno convinto gli occhi del mio piccolo Yanis. Fino a quel momento provavo solo vergogna, incapacità a reagire, adesso sento che qualcosa devo fare e soprattutto devo farlo per fare in modo che io non sia ricordato solo come un farabutto o un baro. Il mio bimbo tra poco comprenderà bene la portata di quello che ho combinato: ho una responsabilità in più». Sai che hai tradito tante persone? «Ho tradito soprattutto me stesso, la mia famiglia, le persone che mi vogliono bene. Per questa vicenda anche il mio matrimonio, che stava già traballando, è naufragato miseramente. So che ho fatto danni irreparabili. So che Pietro e Matteo Algeri, persone degnissime e bravissime come gran parte del personale che lavorava alla Saunier Duval hanno visto infrangere il loro sogno, hanno perso il lavoro e una delle cause è la mia stupidità. Per questo per quattro anni mi sono sentito un cane bastonato e adesso non mi sento certamente meglio. Per questo non avevo la forza e il coraggio di guardare negli occhi le persone. Ora però lo devo fare. Ci devo almeno provare. Mi sento un po’ come quei tossici che finiscono nei centri di recupero e poi ci restano per dare un loro contributo er salvare chi a sua volta è finito nello stesso vortice. Ecco, io vorrei chiedere a Renato Di Rocco un incontro per potermi mettere a sua disposizione. A disposizione del Coni. A disposizione dell’Uci. Voglio andare in giro per scuole e società a raccontare quello che ho combinato e come ci si sente quando si tocca il fondo, quando ci si sente emarginati. Quali sono le conseguenze di queste stronzate. So che posso e devo fare qualcosa per il bene di uno sport che io ho amato alla follia e che ho infangato in maniera forse irrimediabile». Sai che non sarà facile… «Lo so, ma ci voglio provare». Hai più sentito Riccardo Riccò? «Mi ha scritto su facebook molto tempo fa, ma io non gli ho dato peso. È un ragazzo che non ha ancora capito la portata di quello che ha combinato. Ha numeri eccezionali, una simpatia contagiosa, avrebbe tutto per piacere, ma deve crescere. Crescere molto. Altrimenti si farà ancora del male. Io non sono mai stato un suo amico, ma ad un certo punto della mia vita mi sono sentito attratto dal fascino di un ragazzo che in quel momento era tutto per il nostro sport. Ma sia ben chiaro, la colpa è solo mia. Sono io che sono stato debole, stupido e irresponsabile». Hai lasciato Sonia, tua moglie (francese), conosciuta nel 2001 e sposata nel 2006. Hai lasciato Montecarlo e sei tornato a vivere a Castelnuovo Magra (La Spezia): come trascorri le tue giornate? «I primi tempi, come ti ho detto, sono stati durissimi. Per quasi un anno non rispondevo al telefono neanche agli amici. Ero annientato. Però ho avuto la fortuna di avere vicino a me la mia seconda “mamma”, Rinetta Lombardi, che conosco dal ’90, da quando sono salito dalla Puglia per provare a diventare un corridore. Lei mi ha accudito e protetto proprio come un figlio. Mi ha aiutato a farmi rialzare dal letto. Le sue figlie, Daniela, Liana e Vania sono la mia seconda famiglia: è in questo contesto familiare che a poco a poco mi sono ritrovato». Cosa ti ha detto “mamma” Rinetta dopo il fattaccio… «Solo chi ha la forza di rialzarsi può sperare di tornare a correre». Oggi sei sereno? «No. Non mi sento in pace con me stesso». Tu in pratica non hai un lavoro? «No, sono disoccupato. Diciamo che ho la fortuna di avere degli angeli custodi. In pratica mi ha adottato Valerio Zamboni, industriale monegasco (vende aerei, ndr), che ha una passione maledetta per la bicicletta e soprattutto per l’ultra-endurance (le RAAM, come la Race Across America, ndr): lo seguo in giro per il mondo quando non sono impegnato con mio figlio». Ma è vero che sei anche il preparatore di Joaquin Rodriguez? «No, non è assolutamente vero. Sono un caro amico di famiglia suo e di sua moglie Yolanda. Ho corso con lui per un paio di stagioni e ho sempre mantenuto ottimi rapporti con Joaquin. Diciamo che di tanto in tanto sento e con il quale ci si confronta. Come del resto faccio anche con altri tre-quattro ragazzi giovani spagnoli molto interessanti. Ecco, anche questa situazione mi fa soffrire in maniera pazzesca, io penso di poter fare delle cose ma non posso farle perché metto in difficoltà il mondo. Se mi lascio andare è la fine, se mi muovo posso solo fare danni. Anche per questo ho deciso di scrivere una lettera al presidente Renato Di Rocco, chiedendogli di poter seguire dei corsi, di poter fare qualcosa direttamente per loro. Detto come va detto, io potrei fare tutto: mi tessero in un altro angolo del mondo, mi appoggio ad un amico e professionista della preparazione e il gioco è fatto. Ma io non voglio più avere a che fare con i sotterfugi. Io non voglio più vivere di furbate ed espedienti: piuttosto non faccio nulla. Io sono nella fogna e vorrei fare le cose alla luce del sole e soprattutto vorrei fare un percorso di riabilitazione con la Federazione, il Coni e l’Uci. Io a loro ho creato un danno enorme, ed è con loro che devo per forza di cose ricominciare. Come direbbe Vasco Rossi, uno dei miei cantautori preferiti: sono ancora qua. Ditemi cosa devo fare e io lo faccio. In tutto e per tutto. Sono un uomo che ha sbagliato, che ha fatto un grosso errore, ma sente di poter fare qualcosa di grande per riscattarsi. Io non chiedo oblio. Tutti devono ricordarsi di quello che ho combinato nell’estate del 2008, ma mi piacerebbe che un giorno qualcuno venisse a conoscenza anche di quello che di buono sono riuscito a fare per riabilitarmi. Per il bene del ciclismo, per i tanti appassionati traditi, per tutti quelli a cui ho recato del male e per Yanis, che non deve vergognarsi di suo papà». di Pier Augusto Stagi, da tuttoBICI di febbraio
Piepoli: ho sbagliato, adesso "usatemi" «Pronto a fare qualsiasi cosa per riscattarmi come uomo» ESCLUSIVO | Non ha voglia di scherzare, lui che ha sempre avuto la battuta pronta e il gusto del paradosso. Non ha voglia di scherzare, ma un maledetto desiderio «di uscire dalla fogna», come ci dice amaro. Leonardo Piepoli non è più un ragazzino, e non ha nemmeno più i lineamenti del ragazzo imberbe e spensierato. Quelli forse non li ha neppure mai avuti, visto che il suo viso disegnato da una barba marcata e precoce lo rendeva più vecchio di quello che era anche agli inizi della sua carriera, quando per tutti era la «pulce di Alberobello» o il «trullo volante». «Ora invece sono solo un citrullo…», dice tra il sarcastico e l’amaro. Ci incontriamo a metà strada, in un locale di Fidenza, appena fuori dall’autostrada. È da quattro anni che si è eclissato, nascosto, annullato dal mondo. Poi una telefonata, a metà gennaio: «Ciao Pier, sono Leo, ti ricordi di me?…». E ancora: «Se sei in imbarazzo evito di andare avanti, posso capire che mi consideri un autentico pezzo di… D’altra parte io stesso mi considero esattamente così». Lo ascolto, parliamo un po’, ci diamo appuntamento per mangiare qualcosa insieme. Ha voglia di parlare, di raccontare quello che ha nella testa e sullo stomaco, ma soprattutto nel cuore. «Vengo da anni difficilissimi, fatti di vergogna e tormenti. I due anni che mi hanno dato per il doping? Sono nulla in confronto a quello che ho pasasto e sto passando. Mi sento un fallito, un perdente, un bandito, uno che è stato capace di rovinare tutto per la propria superficialità e il proprio ego. Oggi io non sono qui a chiedere di essere perdonato e capito, perché sono il primo che non si perdonerà mai. Non sono nemmeno qui a chiedere il diritto d’oblio, anzi, io la penso esattamente al contrario. Ho letto che ci sono personaggi del mondo della politica o dello spettacolo che fanno scrivere dall’avvocato affinché i giornali e i mezzi di comunicazione non facciano più riferimento a cose del loro passato, io questo non lo trovo giusto. Io so che ho sbagliato e so anche che chiunque e per tutta la vita ha il diritto di dire quello che feci in quella estate del 2008. Un conto però è ammettere i propri errori e un altro è fare qualcosa per poter diventare un uomo migliore. Ecco, io sono qui perché dopo aver visto gli occhi di mio figlio Yanis (5 anni, ndr), voglio che lui sappia che papà ha sbagliato, che è stato un cretino, ma che un giorno ha anche avuto la forza di rialzarsi e ha saputo fare qualcosa di importante per ritrovare la strada maestra». Leo, cosa è successo nell’estate del 2008? «Mi sono sentito un padreterno. Mi sono sentito un dio, che era considerato e veniva considerato da Riccardo Riccò qualcosa di molto importante. Riccardo in quel momento era davvero tanto per il ciclismo italiano e mondiale. Dopo Armstrong c’era lui e Riccardo voleva me al suo fianco. Io ero il suo alter ego: per me il massimo del massimo. In quel periodo pensavo a cosa potessero provare gli uomini di fiducia di Marco Pantani: cose da perdere la testa. Difatti io l’ho persa. A maggio mi ero ritirato dal Giro d’Italia: cado lungo la discesa del Falzarego, mi fratturo quattro costole e abbandono. In programma c’è la Vuelta, ma Riccardo mi chiede di andare con lui al Tour: sono affascinato dall’idea. E soprattutto lusingato». E poi?… «Potrei limitarmi ad aiutarlo, a fare quello che ho sempre fatto nella mia carriera: far vincere i miei capitani. Invece nell’euforia del momento perdo il senno, e mi faccio abbacinare dall’idea di poter fare qualcosa di grande. Entro in quel tunnel fatto di delirio di onnipotenza ed eccitazioni, convinto da chi di solito ti dice che tanto nessuno ti può beccare, e io poi stupidamente mi do anche una giustificazione: sono un po’ giù di preparazione, è giusto che un aiutino me lo dia. Incoscienza allo stato puro. Salgo su una giostra sulla quale non sarei mai dovuto salire. Riccardo per me è stato come Lucignolo con Pinocchio: io davvero ho avuto la testa di legno. Mi sono fatto ingolosire come un bimbo davanti ad una pasticceria. All’Hautacam vinco. Quel giorno so di aver rubato. Sento di averla fatta fuori dal vaso. Quello che dovrebbe essere il momento più bello della mia carriera, in verità si rivela il più brutto e buio di tutti. Io sono a disagio con me stesso. So quello che valgo, so quello che potrei fare con le mie sole forze». Tu prima, nella tua lunga carriera (14 anni di professionismo), mai avevi fatto ricorso alla chimica? «In pochissime occasioni. Quasi subito capii quello che ero. Di una cosa sono certo: anche se avessi preso tutto il doping del mondo io non sarei mai potuto diventare né Pantani né tantomeno Armstrong. Ma se è per questo nemmeno un Riccò o un Virenque, per essere chiari. Io ho sempre avuto un buon motore, capace di poter rendere nelle corse di una settimana: una tappa davvero dura e basta. Non per niente ho fatto incetta di Subida a Urkiola, o tappe e classifica finale al Giro d’Aragona o a quello delle Asturie. Difatti, su quelle mi sono specializzato. Quell’anno, invece, ho deciso di combinarla davvero grossa». Chi ti ha dato il Cera: un medico? «No, nessun medico. I medici spesso non centrano assolutamente niente. I pasticci li fanno i corridori, altro che storie». Perché non hai confessato subito le tue colpe? «Perché la cosa era più grande di me. Avevo paura, non sapevo cosa fare. Mi era crollato il modo addosso. Ho cominciato a correre a 9 anni. Da Alberobello avevo lasciato mamma Antonia, papà Oronzo e mia sorella Julia per andare a cercar fortuna al Nord. Prima in Piemonte con la Madonna di Campagna, poi al Casano con Luca Colombo e i fratelli Tomi, poi un anno in Friuli al Caneva e poi ancora al Casano. Tanti sacrifici, ma anche tanta passione. Per me il ciclismo era tutto. In un momento, al Tour, ho gettato alle ortiche tutto e mi sono trovato senza forze. Annientato, e incapace di capire cosa fare della mia vita. Una sensazione che è durata parecchio e che per certi versi non è ancora del tutto scomparsa. Sia chiaro: non ho mai cercato di essere perdonato. Oggi vivo ancora il profondo sconvolgimento di certi miei atti. Quando quest’estate ho letto le dichiarazioni del presidente dell’Uci Pat McQuaid che diceva che non ci deve essere più posto per chi ha barato, io mi sono sentito morire. Sì, si può morire anche guardando il mare... Oggi vivo di rimorsi, angosce e incubi. Mi ritornano in mente un sacco di orribili e angoscianti flash di momenti che mi hanno violentemente provato, momenti che vorrei evitare ad altri. Ho letto la tua intervista al pm di Padova Benedetto Roberti: capisco la sua posizione, la sua rabbia, ma penso che oggi il ciclismo sia molto meglio di quello di ieri. Più pulito del mio, per intenderci. Il ciclismo non è quello che racconta lui, non è il circuito Udace, non è nelle confessioni di persone disperate che compiono atti scellerati o di chi dice di aver visto qualcuno che al posto della borraccia aveva una flebo. Il ciclismo è nelle mani e negli occhi di tutti quei ragazzi - grandi e piccoli -, che rincorrono un sogno. Il ciclismo è nelle mani di chi si accampa e trascorre ore e ore a bordo strada per vedere una tappa di montagna. È nelle mani di quei corridori che hanno accettato e voluto il sistema Adams e anche il passaporto biologico. È nelle mani di quelle persone che hanno fatto una vera lotta al doping, dando la caccia ad intoccabili che evidentemente nel ciclismo non esistono: vedi il caso di Lance Armstrong. Non c’è da inventarsi niente, c’è solo da continuare nella direzione dell’Adams e del passaporto biologico. Bisogna andare avanti con i controlli interni e a sorpresa. C’è da adottare semplicemente il terrorismo psicologico: ragazzi, sappiate che noi siamo in grado di trovare tutto e tutto troveremo». Perché gli sportivi dovrebbero crederti? «Hanno tutto il diritto di considerarmi per quello che sono: uno che non ha giustificazioni. Ma sono qui per poter chiedere scusa. Io non voglio né medaglie né pacche sulla spalla. Ho passato mesi a far fatica ad alzarmi dal letto. O stavo a letto e rinunciavo a vivere, o mi alzavo e decidevo di fare qualcosa di buono dopo aver fatto qualcosa di tremendamente brutto. Come ti ho detto, mi hanno convinto gli occhi del mio piccolo Yanis. Fino a quel momento provavo solo vergogna, incapacità a reagire, adesso sento che qualcosa devo fare e soprattutto devo farlo per fare in modo che io non sia ricordato solo come un farabutto o un baro. Il mio bimbo tra poco comprenderà bene la portata di quello che ho combinato: ho una responsabilità in più». Sai che hai tradito tante persone? «Ho tradito soprattutto me stesso, la mia famiglia, le persone che mi vogliono bene. Per questa vicenda anche il mio matrimonio, che stava già traballando, è naufragato miseramente. So che ho fatto danni irreparabili. So che Pietro e Matteo Algeri, persone degnissime e bravissime come gran parte del personale che lavorava alla Saunier Duval hanno visto infrangere il loro sogno, hanno perso il lavoro e una delle cause è la mia stupidità. Per questo per quattro anni mi sono sentito un cane bastonato e adesso non mi sento certamente meglio. Per questo non avevo la forza e il coraggio di guardare negli occhi le persone. Ora però lo devo fare. Ci devo almeno provare. Mi sento un po’ come quei tossici che finiscono nei centri di recupero e poi ci restano per dare un loro contributo er salvare chi a sua volta è finito nello stesso vortice. Ecco, io vorrei chiedere a Renato Di Rocco un incontro per potermi mettere a sua disposizione. A disposizione del Coni. A disposizione dell’Uci. Voglio andare in giro per scuole e società a raccontare quello che ho combinato e come ci si sente quando si tocca il fondo, quando ci si sente emarginati. Quali sono le conseguenze di queste stronzate. So che posso e devo fare qualcosa per il bene di uno sport che io ho amato alla follia e che ho infangato in maniera forse irrimediabile». Sai che non sarà facile… «Lo so, ma ci voglio provare». Hai più sentito Riccardo Riccò? «Mi ha scritto su facebook molto tempo fa, ma io non gli ho dato peso. È un ragazzo che non ha ancora capito la portata di quello che ha combinato. Ha numeri eccezionali, una simpatia contagiosa, avrebbe tutto per piacere, ma deve crescere. Crescere molto. Altrimenti si farà ancora del male. Io non sono mai stato un suo amico, ma ad un certo punto della mia vita mi sono sentito attratto dal fascino di un ragazzo che in quel momento era tutto per il nostro sport. Ma sia ben chiaro, la colpa è solo mia. Sono io che sono stato debole, stupido e irresponsabile». Hai lasciato Sonia, tua moglie (francese), conosciuta nel 2001 e sposata nel 2006. Hai lasciato Montecarlo e sei tornato a vivere a Castelnuovo Magra (La Spezia): come trascorri le tue giornate? «I primi tempi, come ti ho detto, sono stati durissimi. Per quasi un anno non rispondevo al telefono neanche agli amici. Ero annientato. Però ho avuto la fortuna di avere vicino a me la mia seconda “mamma”, Rinetta Lombardi, che conosco dal ’90, da quando sono salito dalla Puglia per provare a diventare un corridore. Lei mi ha accudito e protetto proprio come un figlio. Mi ha aiutato a farmi rialzare dal letto. Le sue figlie, Daniela, Liana e Vania sono la mia seconda famiglia: è in questo contesto familiare che a poco a poco mi sono ritrovato». Cosa ti ha detto “mamma” Rinetta dopo il fattaccio… «Solo chi ha la forza di rialzarsi può sperare di tornare a correre». Oggi sei sereno? «No. Non mi sento in pace con me stesso». Tu in pratica non hai un lavoro? «No, sono disoccupato. Diciamo che ho la fortuna di avere degli angeli custodi. In pratica mi ha adottato Valerio Zamboni, industriale monegasco (vende aerei, ndr), che ha una passione maledetta per la bicicletta e soprattutto per l’ultra-endurance (le RAAM, come la Race Across America, ndr): lo seguo in giro per il mondo quando non sono impegnato con mio figlio». Ma è vero che sei anche il preparatore di Joaquin Rodriguez? «No, non è assolutamente vero. Sono un caro amico di famiglia suo e di sua moglie Yolanda. Ho corso con lui per un paio di stagioni e ho sempre mantenuto ottimi rapporti con Joaquin. Diciamo che di tanto in tanto sento e con il quale ci si confronta. Come del resto faccio anche con altri tre-quattro ragazzi giovani spagnoli molto interessanti. Ecco, anche questa situazione mi fa soffrire in maniera pazzesca, io penso di poter fare delle cose ma non posso farle perché metto in difficoltà il mondo. Se mi lascio andare è la fine, se mi muovo posso solo fare danni. Anche per questo ho deciso di scrivere una lettera al presidente Renato Di Rocco, chiedendogli di poter seguire dei corsi, di poter fare qualcosa direttamente per loro. Detto come va detto, io potrei fare tutto: mi tessero in un altro angolo del mondo, mi appoggio ad un amico e professionista della preparazione e il gioco è fatto. Ma io non voglio più avere a che fare con i sotterfugi. Io non voglio più vivere di furbate ed espedienti: piuttosto non faccio nulla. Io sono nella fogna e vorrei fare le cose alla luce del sole e soprattutto vorrei fare un percorso di riabilitazione con la Federazione, il Coni e l’Uci. Io a loro ho creato un danno enorme, ed è con loro che devo per forza di cose ricominciare. Come direbbe Vasco Rossi, uno dei miei cantautori preferiti: sono ancora qua. Ditemi cosa devo fare e io lo faccio. In tutto e per tutto. Sono un uomo che ha sbagliato, che ha fatto un grosso errore, ma sente di poter fare qualcosa di grande per riscattarsi. Io non chiedo oblio. Tutti devono ricordarsi di quello che ho combinato nell’estate del 2008, ma mi piacerebbe che un giorno qualcuno venisse a conoscenza anche di quello che di buono sono riuscito a fare per riabilitarmi. Per il bene del ciclismo, per i tanti appassionati traditi, per tutti quelli a cui ho recato del male e per Yanis, che non deve vergognarsi di suo papà». di Pier Augusto Stagi, da tuttoBICI di febbraio